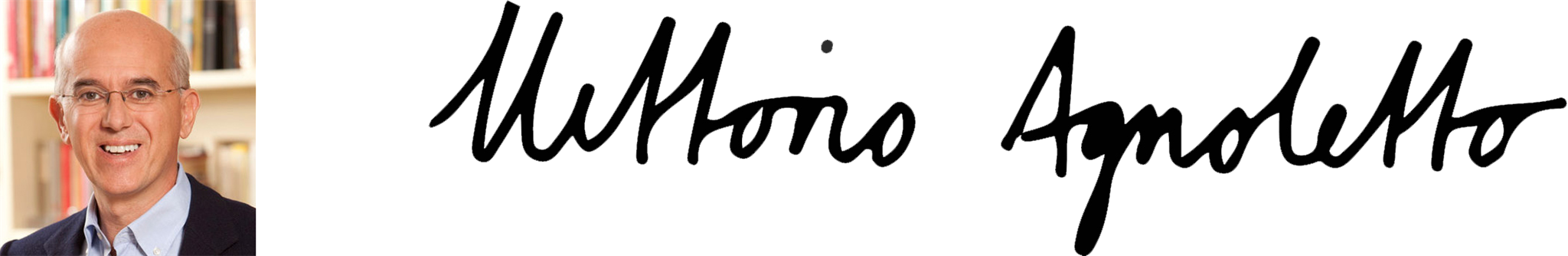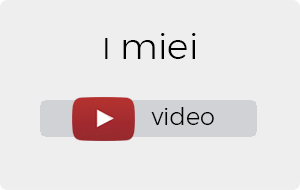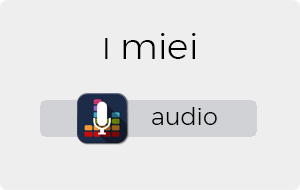Questa storia potremmo titolarla “dall’antimafia alla macelleria messicana, e ritorno”. È una storia che riguarda in questi giorni alcuni altissimi ex dirigenti di polizia, allontanati dal servizio – interdetti per 5 anni dai pubblici uffici – perché condannati in via definitiva, nel luglio scorso, per i falsi e gli abusi compiuti alla scuolaDiaz. Ma è una storia che ha pure una rilevanza generale, perché ci dice qualcosa sulla cultura dell’antimafia – in politica e in magistratura – e su certe sue debolezze. Getta anche luce, questa storia, sulle ragioni per cui la spaventosa caduta di etica pubblica mostrata dai vertici di polizia dal 2001 in poi non ha scandalizzato quasi nessuno negli ambienti del centrosinistra italiano, come dimostrano vari elementi: dalle lodi congiunte espresse in morte del capo della polizia Antonio Manganelli, all’indifferenza che circonda la totale assenza di provvedimenti disciplinari e organizzativi dopo la clamorosa sentenza Diaz, che nell’estate scorsa ha annichilito il vertice di polizia che si era affermato attorno alla figura di Gianni De Gennaro, il più importante dei poliziotti italiani, cresciuto non a caso nella lotta alla mafia e considerato “amico” negli ambienti politici del centrosinistra.Dicevamo che i dirigenti condannati per gli abusi e i falsi alla scuola Diaz hanno lasciato il lavoro, ma non sono entrati in carcere, perché le pene di tre, quattro massimo cinque anni inflitte dai tribunali sono state ridotte di tre anni dal vituperato indulto (qualcuno ricorda lo sdegno del “partito dell’ordine” quando fu introdotto nel 2006?). Resta quindi solo un breve residuo di pena da scontare, per il quale è possibile chiedere l’affidamento ai servizi sociali. E questo è il punto della questione.
RITORNO ALLE ORIGINI. È uscita sui giornali genovesi, ignorata dai media nazionali, la notizia che i due dirigenti di grado più alto fra i condannati –Francesco Gratteri e Gilberto Caldarozzi, rispettivamente capo dell’anticrimine e capo dello Sco fino al 5 luglio 2012, data della sentenza di Cassazione sul caso Diaz – stanno attualmente prestando servizio volontario per tre giorni alla settimana agli sportelli della Fondazione antiusura, organizzazione diretta da Tano Grasso, protagonista negli anni ’90 della lotta in Sicilia contro il racket e in seguito anche parlamentare eletto per i Democratici di sinistra. Un terzo funzionario, a quel che si dice (ma la notizia non è uscita sui giornali e attende conferma ufficiale), è in servizio volontario nella sede del Gruppo Abele, forse il maggiore protagonista in Italia della lotta sociale alla mafia in quanto capofila di Libera.
Questo lodevole impegno volontario, per gli ex dirigenti di polizia è la premessa alla richiesta di assegnazione al medesimo servizio come pena alternativa al carcere. Una richiesta che sarà valutata dal tribunale di sorveglianza il 10 aprile. Il giudice dovrà stabilire se concedere questa opportunità sulla base di una serie di criteri che includono i precedenti penali (in questo caso assenti) dei condannati ma anche il pentimento e la volontà di “redimersi” rispetto ai reati compiuti: e qui ci sarebbe molto da discutere, visto l’atteggiamento tenuto dagli imputati e dai vertici di polizia dal 2001 in poi.
Diciamolo subito e chiaramente: nessuno ha mai mostrato segni di pentimento o di riconoscimento delle proprie responsabilità; nessuno ha davvero collaborato con la giustizia; tutti sono rimasti al loro posto – alcuni sono stati anche promossi – nonostante i processi e le condanne, senza nemmeno ipotizzare la necessità di fare un passo indietro, fino all’inevitabile sospensione del 2012, decisa però dalla magistratura, non dal capo della polizia o dal ministro. Deciderà il giudice se qualcuno sarà meritevole dell’assegnazione ai servizi sociali, punto sul quale Tano Grasso pare non avere dubbi, viste le sue dichiarazioni fatte al Secolo XIX, nelle quali non si fa menzione di Genova G8: “Francesco Gratteri – ha detto Grasso – è un gigante della lotta al crimine. E io sono onorato di potermi avvalere della sua professionalità”. Punto.
LA FORZA DEL GRUPPO. Veniamo allora alla questione dell’antimafia. Francesco Gratteri e Gilberto Caldarozzi, con Antonio Manganelli e Gianni De Gennaro, di qualche anno più anziani, sono fra i poliziotti più in vista nel nostro paese e hanno vissuto in Sicilia negli anni ‘80 e ‘90 la stagione della lotta alla mafia a fianco del Pool di magistrati che aveva in Giovanni Falcone il suo uomo di punta. A quella scuola si sono formati e sull’onda di quell’esperienza Gianni De Gennaro – il leader riconosciuto di quel gruppo di investigatori – è arrivato fino al vertice di polizia, per decisione del presidente del consiglio Giuliano Amato. Era il 2000. L’intero gruppo De Gennaro, con ruoli diversificati, si è così trovato alla guida della polizia di stato. Ma appena un anno dopo, ha rischiato d’essere spazzato via per la disastrosa gestione del G8 di Genova, chiuso con un bilancio spaventoso: un ragazzo ucciso a colpi di pistola (non accadeva dal 1977); un uso della forza del tutto sproporzionato rispetto a quel che accadeva in piazza; una perquisizione alla scuola Diaz incredibilmente violenta quanto maldestra, nonché accompagnata da una serie impressionante di falsi e avvenuta alla presenza di altissimi dirigenti di rango nazionale; la scoperta che nella caserma di Bolzaneto si erano maltrattati decine di cittadini inermi.
L’intero gruppo, da De Gennaro in giù, è invece rimasto in sella, confermato dal governo del momento -guidato da Silvio Berlusconi- e da quelli che sarebbero venuti dopo, presieduti da Romano Prodi, ancora Berlusconi e infine Mario Monti. Il tutto con un costante sostegno politico bipartisan, dal 2001 in poi. Per il centrosinistra -che sentiva e sente quei funzionari come appartenenti al proprio “campo”- e per il centrodestra, il gruppo De Gennaro è sempre stato, e possiamo dire resta, un team di funzionari capaci e affidabili, degni della massima fiducia ed esentati da qualsivoglia critica. Pazienza se a Genova nel 2001 sotto la loro responsabilità – nel caso Diaz anche con presenza fisica sul posto – i diritti umani e costituzionali di decine di persone sono stati calpestati. Pazienza se in quei giorni la polizia di stato ha scritto la pagina più nera della propria storia degli ultimi decenni. Pazienza se negli anni seguenti l’azione della magistratura, impegnata ad individuare i responsabili degli abusi, sia stata ostacolata in ogni modo, violando i più elementari principi di lealtà istituzionale e spesso superando anche il limite della decenza (leggere, per credere e restare attoniti, i verbali delle intercettazioni del processo per falsa testimonianza a carico dell’ex questore Francesco Colucci). Pazienza se nessuno ha collaborato coi magistrati nel’indagine per il tentato omicidio di Mark Covell, pestato selvaggiamente vicino al canncello della scuola Diaz sotto gli occhi di decine di agenti. Pazienza se all’indomani della sentenza di Cassazione per il caso Diaz il dottor De Gennaro, nel frattempo divenuto sottosegretario, ha espresso solidarietà ai funzionari condannati, senza sentirsi minimamente responsabile di alcunché. E pazienza anche se il capo della polizia Manganelli, invece di dimettersi, ha pronunciato una sibillina, oltre che tardiva e reticente, frase di scuse, priva di implicazioni concrete in termini di sospensioni o rimozioni . Pazienza – ancora – se nulla è avvenuto dopo la clamorosa sentenza del luglio 2012 e l’estromissione dalla polizia dei vari Gratteri, Caladarozzi, Luperi, Mortola: il capo della polizia è rimasto al suo posto, il sottosegretario De Gennaro anche; non sono stati avviati procedimenti disciplinari contro chicchessia; i funzionari non colpiti dall’interdizione, per via dei reati caduti in prescrizione, sono rimasti al loro posto; non si è dato il minimo segno di comprensione della gravità e dell’importanza del messaggio arrivato dalla Cassazione: nessuna riforma è stata avviata, nessuna regola su sospensioni e rimozioni dei funzionari sotto processo è stata introdotta, nessun organismo di verifica interna dei comportamenti è stato introdotto.
LA SCUOLA ANTIMAFIA. Per Tano Grasso, come abbiamo visto, il dottor Gratteri è solo “un gigante della lotta al crimine”: quel che è accaduto alla Diaz la notte del 21 luglio 2001 e negli anni seguenti non conta. Lo stesso si può dire di chi ha lodato il dottor Manganelli come campione della lotta al crimine, rimuovendo tutto, davvero tutto, della terribile gestione del G8 e del dopo G8 da parte della polizia di stato dal 2001 in poi (De Gennaro fino al 2007, Manganelli dal 2007 in avanti). Gli elogi sono stati simili e a senso unico, con minime distinzioni fra destra e sinistra, fra il Giornale e il manifesto, fra Corriere della Sera e la Repubblica. Perché siamo arrivati a tanto? Come è possibile che anche esponenti della sinistra come Nichi Vendola o Antonio Ingroia abbiano elogiato Antonio Manganelli e la “sua” polizia con le stesse parole dei loro antagonisti politici, rimuovendo fatti storici enormi come gli abusi di Genova G8, l’indecente conflitto ingaggiato con la magistratura, le clamorose sentenze su Diaz e Bolzaneto?
Una risposta definitiva è difficile, perché stiamo parlando di un’area del potere assai poco trasparente e di rapporti politici e personali non proprio chiari. Ma la sensazione è che l’appartenenza al gruppo che ha fatto la storia della lotta antimafia in polizia, sia diventata in Italia una sorta di salvacondotto politico e morale. Potremmo dire che la storia personale e pubblica di questi funzionari, e quindi -visti i ruoli ricoperti- la storia della stessa polizia di stato, è stata riscritta nel discorso pubblico corrente cancellando un’intera fase storica -dal 2001 in poi- e quindi gli innumerevoli motivi di imbarazzo che l’hanno caratterizzata.
La lunga stagione dell’antimafia è stata un crocevia nel quale si sono incontrati e sono cresciuti professionalmente esponenti delle forze di polizia, della magistratura, del mondo politico e della cittadinanza attiva. Queste persone hanno agito per anni fianco a fianco, forgiando una comune visione dello stato e del concetto di legalità. È facile immaginare che si sia formata fra loro una rete di relazioni personali e professionali molto stretta, con sentimenti di reciproca stima. Non c’è niente di male in tutto ciò, e anzi dalle buone relazioni umane fra persone impegnate in ambiti diversi, può scaturire un’azione pubblica molto efficace.
Nel nostro caso c’è stato però un effetto collaterale piuttosto grave e cioè l’annebbiamento, in certi casi l’annullamento, della capacità di giudicare spassionatamente, sotto il profilo politico e morale, la condotta dei propri “vicini”. È vero che settori importanti dell’antimafia sociale parteciparono alle mobilitazioni contro il G8 del 2001 e in seguito hanno denunciato le violenze della polizia, ma le parti civili, gli avvocati, i Comitati nati dopo il G8 fra cittadini e familiari delle vittime degli abusi si sono trovati pressoché soli nella loro battaglia civile, una battaglia che ha avuto come controparte proprio il vertice della polizia, protetto in modo attivo dalle principali forze politiche e dai ministri che via via si sono succeduti.
La polizia di stato, nella lunga gestione De Gennaro-Manganelli, ha mostrato un’evidente incapacità di avviare un’autocritica e anche di sottoporsi a una trasparente e libera verifica dei comportamenti da parte della magistratura. Funzionari e dirigenti dalle brillanti carriere, ammirati per l’azione antimafia degli anni precedenti, hanno miseramente fallito di fronte alle accuse formulate dai magistrati sulla base delle denunce di decine di cittadini vittime di una serie impressionante di abusi. Hanno fallito perché hanno scelto di usare il prestigio e i ruoli acquisiti sul campo come uno scudo, negando la verità, opponendo il silenzio alle domande dei magistrati, rifiutando una sincera e leale assunzione di responsabilità, con tutto ciò che avrebbe comportato, a cominciare – certo – da un passo indietro nelle rispettive carriere. Mentre questo fallimento era in corso, e ancora oggi che esso è conclamato e certificato dalle sentenze della magistratura, nessuno, fra i più “vicini” a questi funzionari, ha fatto niente per aiutarli ad agire nella direzione giusta.
L’amicizia, i legami, le relazioni di stima cementati nel passato hanno probabilmente impedito di vedere, capire e quindi agire. Si è preferito osservare e semmai solidarizzare, spesso ancorandosi a una visione rigida e schematica di ciò che si intende per “senso dello stato”, una visione coltivata in ambienti politici e giudiziari e che privilegia di fatto lo spirito di corpo rispetto alla libertà di giudizio, la sostanza dei risultati raggiunti o da raggiungere rispetto alle forme e ai metodi dell’azione.
È così che l’inerzia dei più consapevoli, il silenzio delle forze e dei personaggi più attivi nella rigenerazione democratica del paese, si sono sommati all’azione di chi ha agito fin dall’inizio per impedire quell’operazione di verità e di pulizia che sarebbe stata necessaria. Le carriere sono state garantire da questa doppia protezione mentre pochi, pochissimi rimanevano sul campo a lottare per ottenere giustizia nei tribunali e un risarcimento morale nella società: parliamo di un pugno di magistrati, di qualche decina di cittadini che non hanno rinunciato a testimoniare e raccontare gli abusi subiti, degli avvocati che li hanno assistiti in processi difficili e sottoposti a ogni genere di pressione.
UNA VIA D’USCITA. Ora viviamo una fase nuova. Le condanne nel processo Diaz sono state uno choc per tutto l’universo dell’antimafia, non solo all’interno della polizia. I tribunali hanno dimostrato che quel pugno di magistrati e giudici, quelle poche decine di cittadini e avvocati avevano ragione nel battersi in solitudine senza guardare in faccia nessuno, senza concedere salvacondotti morali. C’è quindi una nuova occasione per agire nella direzione dell’interesse pubblico.
Alcuni dei funzionari condannati stanno cercando accoglienza nell’universo dell’antimafia sociale, tornando in qualche modo alle origini. È un fatto positivo, perché la redenzione attiva del reo è un preciso interesse sociale, una nobile finalità della giustizia. Ma stavolta il silenzio non è accettabile. Gli aspetti più sgradevoli delle singole carriere e della nostra storia recenti non possono essere rimossi. Non basta dire, per rifarsi alle parole di Tano Grasso, che il dottor Gratteri è “un gigante dell’anticrimine” e tacere sul resto. Non basta lodare il defunto Antonio Manganelli come “servitore dello stato” e come artefice di importanti azioni contro la criminalità organizzata, ignorando i pesanti errori di gestione del post Genova G8, come hanno fatto, per dire, un ex vice presidente della commissione parlamentare antimafia come Nichi Vendola o un magistrato di prima linea passato alla politica come Antonio Ingroia, giusto per citare personaggi influenti e impegnati in politiche di cambiamento. Non basta aprire con discrezione i propri uffici a persone condannate che chiedono di evitare il carcere e di rendersi utili nel periodo di pena da scontare, senza avvertire la responsabilità di dare un contributo alla ricerca di un’uscita dal vicolo cieco nel quale la polizia di stato si è trincerata.
Quel che davvero serve, oggi, è un intervento profondo all’interno della forze dell’ordine. E c’è bisogno di una parola chiara verso la cittadinanza. Le condanne della magistratura non hanno il semplice scopo di infliggere una pena a questo o quel funzionario: sono anche un messaggio alle istituzioni sulla necessità di cambiare le cose, un invito a prendere provvedimenti. Interventi che finora non ci sono state. La chiusura è stata totale. Non si parla, in nessun ambito, di riforme non più rinviabili, come la riconoscibilità degli agenti in servizio di ordine pubblico o l’istituzione di un organismo indipendente di verifica dell’operato delle forze dell’ordine. Non si parla di una smilitarizzazione generale dei vari corpi di sicurezza e si permette una riserva totale dei posti in polizia a chi abbia svolto un periodo di servizio militare volontario. La polizia di stato è immobilizzata dalla sua totale autoreferenzialità e così le altre forze dell’ordine, sempre più opache e sempre più refrattarie a forme di verifica e controllo dall’esterno. Le forze politiche democratiche non osano agire, paralizzate dai propri vizi e dai propri errori, vittime di una debolezza culturale così profonda da impedire anche un ascolto attento di ciò che si muove nella società, sia pure in mezzo a mille difficoltà.
Eppure una nuova stagione di riforme democratiche, nello spirito della Costituzione, dev’essere concepita, se vogliamo mantenere (o per certi versi riportare) le forze dell’ordine nell’orbita democratica e costituzionale.
È troppo chiedere ai protagonisti dell’antimafia sociale di pronunciarsi su questi temi nel momento in cui accolgono i funzionari e dirigenti di polizia condannati? È troppo chiedere di dire una parola chiara, netta, su quanto siano intollerabili gli abusi compiuti a Genova nel 2001? Sulla protervia osservata dal vertice della polizia di stato negli anni seguenti? Su quanto siano necessari provvedimenti concreti, ricambi veri?
Possiamo chiedere di sgomberare il campo dalle ambiguità?