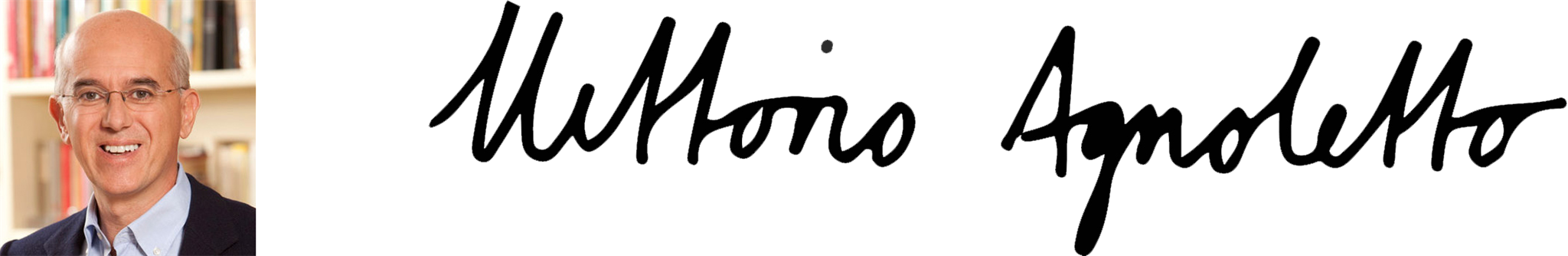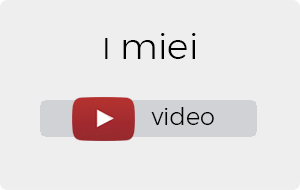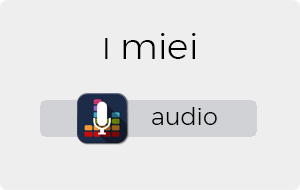Il dramma dei migranti al centro della terza giornata dell’Incontro dei movimenti popolari
di Claudia Fanti – agenzia Adista
Con il pensiero rivolto all’impressionante numero di vite spezzate nel tentativo di assicurare per sé e per i propri cari un futuro migliore – alle innumerevoli volte in cui, dalle coste del Mediterraneo al deserto dell’Arizona, è rimasto senza risposta il grido rivolto a Caino «Che hai fatto di tuo fratello?» – si è aperta, nel terzo giorno di lavori dell’Incontro Mondiale dei Movimenti Popolari, la plenaria sull’ultimo dei tre grandi temi al centro della riflessione dei delegati e delle delegate: quello dei rifugiati e degli sfollati.
Un dramma che, come ha evidenziato il messicano Carlos Marentes, del Progetto dei Lavoratori Agricoli di Frontiera, non è altro che il frutto più tragico del sistema di morte capitalista in tutti i suoi molteplici aspetti: quelli dei conflitti armati, della criminalità organizzata, delle catastrofi climatiche, dell’ingiustizia economica, delle discriminazioni sociali. E per quanto i numeri siano spaventosi – 100mila gli sfollati in appena 8 giorni, tra ottobre e novembre, in seguito ai bombardamenti in Siria; 200mila i messicani costretti a fuggire in conseguenza della guerra al narcotraffico voluta dagli Usa; 100mila i rifugiati climatici appena negli Stati Uniti, solo per fare alcuni esempi – le cifre non potranno mai, da sole, rendere l’esatta portata di questa tragedia. Una tragedia espressa dalle innumerevoli storie di speranze tradite e di dolore, le storie di «milioni di persone espulse dalle loro case e dalle loro terre che cercano – molte volte morendo in questo tentativo – di entrare in Paesi che non le vogliono». Che sono poi – ha sottolineato Marentes – gli stessi Paesi responsabili del fenomeno della migrazione forzata: «È attraverso la lente del colonialismo che bisogna leggere il fenomeno migratorio», risultato degli interminabili abusi commessi dai conquistatori e dai loro eredi, contro cui i popoli resistono e lottano da 524 anni. Una lotta di cui un simbolo straordinario è quello della battaglia del popolo sioux in Nord Dakota contro l’oleodotto che dovrebbe attraversare la sua riserva, su cui «la Chiesa statunitense sta mantenendo uno sconcertante silenzio». E se l’enorme debito sociale generato dal brutale saccheggio dei colonialisti di ieri e di oggi non è mai stato risarcito, è come una forma di riscossione di tale debito che, secondo Marentes, va interpretato il fenomeno migratorio, a cui dunque bisogna guardare come a «una forma di resistenza contro il destino a cui il capitale ha condannato le persone migranti, una lotta per non scomparire in un sistema in cui è negato loro un posto».
È tutto questo che hanno espresso le storie al centro della sessione dedicata a un fenomeno, quello appunto dei rifugiati e degli sfollati, che può essere compreso appieno solo da chi lo ha vissuto sulla propria pelle, come ha sottolineato monsignor Silvano Tomasi, del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, che proprio per questo ha voluto attraversare il confine tra Tijuana e San Diego con alcuni migranti senza documenti, sfidando insieme a loro la polizia di frontiera.
La storia, per esempio, di quei contadini del Sud del Messico che, mandati in rovina dalle pratiche delle multinazionali e dai Trattati di libero commercio, salgono al Nord per vendere le proprie braccia alla filiera agroalimentare statunitense, finendo per subire abusi di ogni tipo dai loro datori di lavoro, dallo Stato e dalla polizia di frontiera. E tutto – ha affermato ancora Marentes – nell’indifferenza di una società che non si chiede cosa ci sia dietro gli alimenti che consuma, come se il cibo non fosse «l’elemento più sacro della vita»: poiché infatti «è attraverso gli alimenti e la produzione di alimenti che passa la nostra vera relazione con la natura, nel momento in cui produciamo cibo dobbiamo prenderci cura del pianeta, dell’integrità della natura, del benessere di nostra sorella Madre Terra».
O, ancora, la storia di Ndao Moustapha, venditore di strada a Barcellona, giunto in Europa per migliorare le proprie condizioni di vita e scontratosi con l’incubo quotidiano della vita di un migrante in Europa: «Fuggiamo da un’Africa – ha affermato nel suo intervento – in cui le cose non fanno che cambiare in peggio, in cui la povertà non fa che acuirsi, in cui governi totalmente corrotti voltano le spalle ai loro popoli, per ritrovarci qui in Europa» ad affrontare governi ostili, polizie violente – «Ti spezzano un braccio, ti rompono una gamba? Non succede niente» -, apparati di giustizia razzisti, leggi disumane che arrivano a negare a chi non ha documenti persino l’assistenza sanitaria («A un mio amico senza documenti, morto di tubercolosi a Palma di Maiorca, un medico ha detto che non poteva neppure visitarlo»). «La vita è dura in Africa. La vita è dura qui. Alla popolazione africana – ha concluso Moustapha – voglio mandare un messaggo: non venite in Europa!».
Le migrazioni forzate in Medio Oriente
Se una sessione dedicata al dramma dei rifugiati e degli sfollati non poteva non affrontare il caso dei popoli curdo e palestinese, ha lasciato sicuramente il segno l’intervento di Nursel Kilic, del Movimento delle Donne Curde, che, a poche ore dall’arresto in piena notte di undici parlamentari curdi del Partito democratico dei popoli (Hdp), tra cui i due principali leader, Selahattin Demirtas e Figen Yuksekdag, accompagnato per di più dall’oscuramento dei social network, ha denunciato quello che, dopo il mancato colpo di Stato in Turchia del 15 luglio scorso, si configura sempre più apertamente come un golpe civile da parte del governo di Erdogan, il quale può disporre oltretutto di una potente arma di ricatto nei confronti dei governi occidentali: «quella di milioni di rifugiati siriani che egli minaccia di spedire in Europa, oltretutto utilizzando parti consistenti dei fondi europei per portare avanti il genocidio del popolo curdo». Alla persecuzione, agli arresti arbitrari, agli assassinii, alle brutali violenze, il popolo curdo, con le donne in prima fila, risponde però, ha spiegato Kilic, con «una proposta rivoluzionaria», guardando non a uno Stato-nazione che ricomprenda i territori attualmente divisi tra Turchia, Iran, Iraq e Siria – avendo quest’ultimo, in quanto ossatura portante del capitalismo moderno, un carattere strutturalmente violento – ma a «una democrazia senza Stato» espressa nella forma del confederalismo democratico, in vista della costruzione di una società libera dall’autoritarismo, dal patriarcalismo, dal militarismo, dal centralismo: un sistema partecipativo che non solo riconosce e applica concretamente la parità di genere, ma abbraccia anche tutte le confessioni religiose e le etnie.
Dal dramma curdo a quello palestinese, Sahar Francis, dell’Unione dei Lavoratori Agricoli della Palestina, ha ripercorso la vicenda del suo popolo a partire dalla fondazione dello Stato di Israele e dalla guerra del 1948, con la conseguente distruzione di oltre 400 villaggi palestinesi e l’espulsione di oltre 700mila persone, costrette a cercare rifugio in Giordania e in Libano. Da allora, ha spiegato, «la popolazione palestinese è stata oggetto del maggior numero di risoluzioni delle Nazioni Unite – compresa quella che, nel 1994, garantiva il ritorno delle persone espulse nei loro territori – tutte rimaste completamente sulla carta: il 97% della terra palestinese è ancora saldamente nelle mani degli israeliani», i quali, dal muro dell’apartheid che attraversa la Cisgiordania agli insediamenti ebraici nei Territori Occupati fino al blocco della Striscia di Gaza, si sono resi responsabili di ogni possibile abuso nei confronti della popolazione palestinese.
Dipendenti dalla solidarietà
Preceduto dalla discussione dei delegati e delle delegate sulle proposte di azione che confluiranno nel documento finale che sarà consegnato a papa Francesco nel pomeriggio di sabato 5 novembre, è stato l’intervento d
i José “Pepe” Mujica – ex presidente dell’Uruguay e ancor prima dirigente del movimento guerrigliero Tupamaro, catturato dal regime e lasciato in prigione, in totale isolamento e in condizioni disumane, per oltre dodici anni (un paio dei quali passati in fondo a un pozzo, praticamente sepolto vivo) – a concludere la terza giornata di lavoro dell’incontro. Celebrato a livello mondiale per la sua onestà e la sua austerità personale, come pure per i successi del suo governo – aumento dei salari e delle pensioni, riduzione del tasso di disoccupazione, diminuzione dell’indice di povertà, più una serie di leggi all’avanguardia in materia di diversità sessuale (matrimonio omosessuale), riproduzione (legalizzazione dell’aborto) e droghe (legalizzazione della marijuana) -, ma anche oggetto delle critiche di una parte della sinistra, che gli ha rimproverato l’azzeramento del conflitto sociale mediante un discorso di conciliazione tra le classi, la rinuncia a realizzare riforme strutturali (ma garantendo programmi assistenziali a favore delle fasce più deboli e adottando provvedimenti nel campo dei diritti sociali e lavorativi) e il sostegno al modello estrattivista, attraverso l’espansione dell’industria forestale, della monocoltura della soia (maggioritariamente transgenica) e dell’attività mineraria, Mujica ha centrato il suo intervento sul valore dell’uguaglianza, affermato dalla Rivoluzione Francese ma presto messo da parte e dimenticato, come indica fin troppo chiaramente la realtà un mondo dominato da un processo mai così accentuato e rapido di concentrazione della ricchezza in poche mani. Un processo che, ha spiegato l’ex presidente, «finisce per diventare concentrazione di potere politico, in una sorta di circolo vizioso segnato da connessioni diaboliche», con conseguente perdita di credibilità della democrazia rappresentativa, espressione sempre più chiara di «una politica che ha smesso di essere passione per trasformarsi in un mestiere». E che, in questo modo, è venuta meno al compito di gestire i conflitti sociali, «imprescindibili come le rughe e i capelli bianchi», inchinandosi al capitale e al suo imperativo di «comprare, comprare e ancora comprare». È in questo quadro che si pone, secondo Mujica, la sfida di chi ha scelto la via della lotta, quella di «mettere la propria esistenza al servizio dell’esistenza degli altri», opponendo alla «dipendenza» dall’accumulo di ricchezze, quella dalla solidarietà nei confronti del prossimo e delle generazioni che verranno, la dipendenza da quell’utopia dell’uguaglianza che «deve guidarci nel divenire storico del genere umano, che sale di un gradino, ne scende due, e poi ancora risale, senza mai ottenere un trionfo definitivo», ma senza neppure lasciarsi mai paralizzare dai fallimenti: «Credo – ha concluso – nella capacità della specie umana di imparare dal dolore, di trarre più lezioni dagli errori che dai successi e di ottenere alla fine risultati importanti».